Cerchiamo di andare due passi oltre le questioni immediatamente visibili della situazione politica del nostro paese.
Di Luca Pardi
Dal 2007- 2008 è iniziato un ciclo di crisi economica che non è mai finito. Dopo la recessione, che ha colpito i paesi sviluppati negli anni immediatamente successivi alla crisi finanziaria, innescata dal fattaccio dei subprime, il sistema globale ha ripreso una parvenza di normalità fino alla crisi del debito sovrano europeo di cui il caso della Grecia è stato il più eclatante. Ma sapevamo che l’Italia veniva in coda. Dopo le cose hanno ripreso a marciare, ma permane uno stato di incertezza e perfino di paura. Cosa sta succedendo? Provo a spiegare il mio modello mentale del mondo e vi invito a seguirmi fino in fondo o lasciarmi subito.
Il sistema capitalistico globalizzato si è sviluppato in una lunga fase di espansione economica (crescita) che, salvo periodi brevi di crisi, va avanti da almeno due secoli e mezzo. Il sistema non è funziona se non c’è crescita. L’idolatria del PIL è nata per questo motivo, non è l’inverso. La crescita avviene consumando il pianeta (biosfera, atmosfera, litosfera ed idrosfera) sia in ingresso (fonti) sia in uscita (discariche) dal sistema economico. La crescita è una crescita materiale, cioè di cose (capitale) e persone (popolazione) e, l’abbiamo visto anche altre volte, anche di individui che non riesco proprio a considerare “cose”, i nostri animali domestici.
Nella storia dello sviluppo capitalistico c’è una fase in cui è potenzialmente possibile crescere per tutti. In questa fase la competizione economica fra aziende e paesi, porta più benefici che costi. Questo non vuol dire che tutti crescono, o che crescono nello stesso modo, ma semplicemente che le risorse estratte dal pianeta sono abbondanti e la potenzialità di crescita esiste per tutti. Crescono di più i più “bravi”, ma, nella media, lo sviluppo è generale. Anche se la media è trilussiana.
Alla fine del secolo scorso si affacciano prepotentemente sul panorama economico diverse grandi nazioni, i cosiddetti BRICS, che nel ‘900 erano rimaste dal punto di vista economico (cioè dello sfruttamento del pianeta) più o meno in disparte. Si tratta di almeno 3 miliardi di persone (nel 1999 anno simbolico in cui la Cina entra nel WTO e si raggiunge una popolazione di 6 miliardi di persone), il 50% della popolazione mondiale, che aspira a raggiungere standard di benessere occidentali. La domanda di materie prime e risorse dal pianeta al sistema economico aumenta ed arrivano a maturazione le prime crisi del flusso materiale di risorse dalla natura all’economia e di rifiuti dall’economia alla natura. Dal momento in cui il flusso di risorse diventa più viscoso e le discariche iniziano a saturarsi, il potenziale di crescita diminuisce, ciò significa che se alcuni paesi o gruppi di paesi crescono, altri devono crescere meno o andare in recessione. Il primo momento cruciale è la fine del petrolio a buon mercato che si presenta con il Picco del Petrolio Convenzionale. Non sappiamo ancora esattamente quando tale picco si sia verificato, anche perché la determinazione della data esatta dipende dalla definizione che si da al petrolio convenzionale, ma sappiamo che l’insieme delle risorse petrolifere che hanno alimentato il sistema economico globale nel XX secolo sono in declino produttivo e che l’aumento della domanda è stato soddisfatto da categorie di petrolio più costose (oli pesanti, shale-oil ecc). Abbiamo già varie volte contestato il fatto che il prezzo del petrolio sia attualmente basso e che ci siano problemi di abbondanza. L’abbondanza c’è ma ad un prezzo del barile che, nella fase del minimo storico, era almeno due volte il prezzo di fine secolo XX.
Probabilmente il processo di aumento della viscosità del flusso materiale è inziato, inavvertito, prima del nostro secolo. Secondo Mauro Bonaiuti, ad esempio, i segnali potrebbero essere già stati attivi negli anni ’70. In pratica questo periodo storico segna l’ingresso in quella che Ugo Bardi definisce l’era dei rendimenti decrescenti. Nella fase iniziale di questa era parte del problema viene differito grazie alla creazione di debito (vedi crescita del debito negli ultimi 30 anni), ma questa non è appunto che una dilazione. Si scommette sulla crescita futura il che significa che il debitore promette di sfruttare di più il pianeta per ripagare il debito con l’interesse. Se questo non succede, a causa della crescente viscosità del flusso di risorse, il debitore va in bancarotta e il sistema inizia ad andare in tilt.
Essenzialmente penso che l’attuale situazione italiana, europea e mondiale sia il prodotto del picco del petrolio convenzionale. Alcuni vedono come il fumo negli occhi l’idea che questa sia una crisi di scarsità e la vedono come un’altra crisi da sovrapproduzione del sistema capitalistico. Personalmente non escludo che sia possibile considerare anche questo aspetto. Ormai sappiamo che fra i fattori di produzione oltre al lavoro ed al capitale ci sono anche le materie prime (la terra di Ricardo) e, in particolare, l’energia.
La globalizzazione ha reso estremamente a buon mercato il fattore lavoro; la fine del cheap oil è stata compensata con la moltiplicazione smisurata del cheap labor per non parlare del cheap environment, cioè della scarsa valutazione dei danni ambientali. Inoltre essa ha permesso la quasi totale liberalizzazione dei movimenti dei capitali finanziari che sono così andati là dove i fattori di produzione erano più favorevoli. Nei paesi di vecchia industrializzazione, già abbastanza irrigiditi sul piano della tutela ambientale, il lavoro non può essere eliminato senza costi per cui nei paesi manifatturieri come l’Italia, economicamente devastati dalla globalizzazione (i PIIGS), e incapaci di competere a livelli tecnologici superiori (come la Germania e il nord Europa) è esploso il debito pubblico. La cosa è evidentemente insostenibile e sinceramente non so dove possa andare a finire. I paesi “bravi” ad esportare reggono la competizione perché sfruttano un vantaggio tecnologico accumulato nel corso di decenni di maggiore sviluppo di scienza e ricerca. Non è detto che i loro cittadini stiano meglio di noi, ma le loro economie sono in grado di mantenere la piena occupazione (e perciò la pace sociale) senza fare debito. L’equilibrio è precario. Non c’è, in Germania come negli Stati Uniti, lo stesso benessere degli anni ’80. Il “popolo minuto” è abbastanza miserevole anche nei paesi economicamente forti, psicofarmaci, droghe, alcool e abuso del cibo dilagano, le patologie psichiatriche e quelle determinate da un cattivo stile di vita aumentano. Ma, soprattutto in Germania, non si forma debito pubblico e anzi, c’è un forte surplus che viene usato politicamente per indicare i “cattivi” dell’Europa. La spirale è pericolosa e non oso pensare a dove possa portare. Quando si iniziano a trovare i capri espiatori di una situazione non felice per mantenere la coesione sociale sappiamo dove si inizia e non si sa dove si finisce. Qualcuno teme il ritorno dell’autoritarismo e del razzismo. Qualcuno pensa che essi siano già alla porta come il proverbiale lupo.
Personalmente penso che una politica ed un’opinione pubblica responsabile dovrebbero rifuggere dall’indicare lo straniero come la causa dei nostri mali, sia esso lo straccione migrante, il ricco tedesco o lo scroccone italiano. Nel nostro paese dovremmo concentrare gli sforzi per aumentare la capacità di affrontare i problemi di scarsità che andranno aggravandosi anno dopo anno. Abbiamo bisogno di un’infrastruttura energetica nuova, basata sulle fonti rinnovabili, abbiamo bisogno di un ambiente risanato e sicuro per la nostra agricoltura e per la nostra salute, e, soprattutto, abbiamo bisogno di rivitalizzare quello che in questo paese non è mai mancata, la rete di solidarietà che tiene insieme una società. Per l’energia e il risanamento abbiamo le conoscenze necessarie, non c’è bisogno di grandi scoperte o invenzioni epocali, basta abbandonare l’illusione della crescita illimitata e senza qualità del consumismo. Probabilmente lo sviluppo energetico e quello ambientale porterebbero comunque un certo grado di crescita con il relativo aumento dell’occupazione che combinato con una equa redistribuzione della ricchezza potrebbe mantenere la coesione sociale che è il bene più prezioso in mancanza del quale la barbarie è inevitabile. Certo le premesse non sono buone, anche i migliori intenzionati si propongono di rilanciare proprio quella crescita indifferenziata basata sull’aumento del consumo pur che sia. Poi ci sono quelli che vogliono continuare a tagliare le spese, anche se nel recente passato l’effetto dell’austerità è stato deleterio. Fra questi, il più feroce assertore dell’austerità: Carlo Cottarelli. Auguri a tutti.
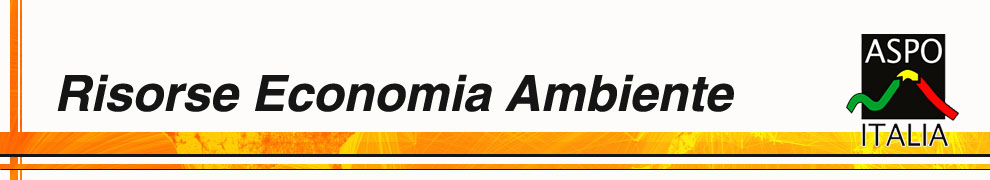




questa frase qua la contesto:
Il sistema capitalistico globalizzato si è sviluppato in una lunga fase di espansione economica (crescita) che, salvo periodi brevi di crisi, va avanti da almeno due secoli e mezzo.
abbiamo avuto due guerre mondiali e la crisi del 29, brevi periodi di crisi?
Nella scala dei secoli, si.
Comunque la questione se le crisi del passato siano brevi o meno è irrilevante nel contesto del mio post. L’importante è che considero questa crisi un’altra cosa rispetto a quelle del passato.
Concordo con entrambi: i 30 anni fra il 1914 ed il 1945 sono stati una crisi sistemica di prima grandezza che ha radicalmente cambiato la struttura stessa del capitalismo. Tuttavia ha ragione Luca: la crisi attuale è di tutt’altra natura e più profonda, anche se per ora almeno infinitamente meno violenta.
Ciao Luca,
nel lucidissimo quadro che proponi tralasci, a mio sommesso avviso, di annotare una caratteristica che presente in tutti i paesi “avanzati” cosa che li distingue, in negativo, da quelli “in via di sviluppo” o “sottosviluppati”: la disgregazione sociale.
Chissà se tale caratteristica dei paesi “più deboli” li doterà di una maggior resilienza nei confronti della crisi. A me tutto questo fa venire in mente Cuba VS Usa.
I più poveri, insomma hanno un senso di unità che il cosiddetto “progresso” ci ha fatto perdere.
Sono d’accordo con te. Infatti a quanto mi è riuscito di capire parlando anche con una collega tedesca noi, da questo punto di vista, siamo messi meglio di loro. Sembra che la disgregazione sociale sia direttamente proporzionale al PIL. E in effetti è sensato. Se hai risorse in abbondanza puoi fare a meno degli altri e di fatto ne fai a meno.
Su questo non sarei troppo sicuro. Entro certi limiti di povertà e all’interno di sistemi sociali relativamente stabili e rodati penso anche io che Stefano Russo abbia ragione. Ma in contesti di maggiore stress (miseria assoluta, competizione fra gruppi diversi ecc.) la guerra fra poveri può diventare quanto di più feroce si possa immaginare.
Al di la dei dettagli, congrats per la sintesi e la chiarezza.
Centra e non centra ma ho appena letto un articolo, forse eccessivamente fantasioso ma forse anche no che posto qui. Sono comunque ragazzi seri quelli che scrivono.
Questo è veramente preoccupante. Almeno per me.
https://secolo-trentino.com/attualita/washington-e-londra-a-difesa-del-governo-populista-legastellato/
Hai scritto meglio di quanto avrei saputo fare io i miei pensieri. Sono da tempo convinto che fenomeni come Brexit, Orban, il gruppo di Visegrád, Trump, l’esplosione generalizzata di sovranismi e populismi, il rifiuto di misurarsi con le crescenti spinte alle migrazioni, l’idea di gonfiare senza fine il debito a sostegno di una crescita sempre più asfittica e distruttiva, siano fatti che presentano proprie specifiche caratteristiche ma tutti con un minimo comun denominatore: la volontà di gruppi organizzati di mantenere quanto ritengono incedibile, accumulato o accumulabile, messo in difficoltà dai ritorni netti decrescenti che caratterizzano i diversi processi di trasformazione delle risorse naturali. Non penso si possa escludere che il capitalismo in qualche situazione “previlegiata” sappia determinare anche sovrapproduzione, ma ciò può ben coesistere con una tendenza generale di segno contrario all’interno della quale chi può si chiude sicuro in trincea e continua ad accumulare mentre gli altri vengono obbligati a uscire sul campo di battaglia a scannarsi.
Storia vecchia ma, mentre in passato caratterizzava fasi , intervallate da altre in cui risultava possibile distribuire un pò di ricchezza anche ai più deboli, penso che oggi ci si sia ormai affacciati a una china che non lascia intravvedere alcuna possibilità reale di invertire significativamente la tendenza. Mala tempora currunt. E il futuro non appare migliore.
mi pare che il post ed i commenti abbiano un unico massimo comun divisore: peak oil. Peccato che siamo una frazione infinitesima, gli altri corrono dietro allo spread.
Venerdì il gruppo soci di Banca Etica aveva organizzato una lezione con una economista sul problema del debito. Molto interessante per le cose discusse qui.
In sintesi, l’Italia è un paese con un’economia abbastanza sana, bilancia commerciale positiva, bilancio statale primario (esclusi i debiti) in attivo, con problemi evidenti ma non insormontabili, quel che ci uccide è il pagamento degli interessi sul debito. Che sono abbastanza contenuti grazie ai bassi tassi che derivano anche dall’euro, ma bruciano circa il 10% della spesa pubblica (3,8% del PIL).
Come è nato il debito? Fino al 1972 la crescita del boom economico permetteva una grossa spesa pubblica. Tanto il PIL cresceva, c’era più ricchezza, più tasse e si poteva pagare gli interessi senza problemi.
La prima crisi petrolifera (e non l’ho imbeccata io) ha scatenato il caos. Il disavanzo primario è passato al 10-12% del PIL, ma tanto Banca d’Italia copriva. Il tutto ha funzionato per un ventennio, sempre peggio. Nel 1992 il disavanzo primario era circa zero, ma gli interessi sul debito pesavano per il 10% del PIL. Il governo Amato, lacrime e sangue, ha permesso di portare il disavanzo al 3%, e da allora siamo lì.
Mia conclusione, per quel che ho capito. Stiamo stallando la situazione, per un po’ si può reggere, ma stiamo in sostanza pagando oggi il debito degli anni ’70, dovuto a una crisi delle risorse che ci eravamo illusi di aver superato ma che abbiamo solo rimandato.
quando tanti anni fa mi accorsi da una pagina della Banca d’Italia che il nostro bilancio commerciale era attivo solo per una partita di giro, poco dopo la pagina sparì. Possiamo pure continuare a credere a tutto quello che ci raccontano, visto che il nostro benessere dipende da questo, ma il collasso ipotizzato da LTG entro il 2030 si avvicina sempre più veloce.
E non è previsione pitonica, ma solo termodinamica.
Secondo il mio umile parere, dalla fine degli anni ’60, dopo aver trascorso un intero ventennio, il primo del secondo dopoguerra, durante il quale in Italia abbiamo conosciuto una crescita economica media del 6 per cento l’anno che ci ha traghettati da una specie di medioevo bucolico ma sovrappopolato e tutt’altro che arcadico fin alla modernita’ industriale, grazie non tanto alla disponibilita’ di energia quanto alla capacita’ di sfruttarla, con il raggiungimento di una ricchezza procapite finale sostanzialmente non molto diversa da quella attuale, poi abbiamo tentato di perseguire a tutti i costi lo stesso tasso di crescita, ormai inutile prima ancora che impossibile, che non ha fatto altro che moltiplicare debito e frustrazione.
La crisi petrolifera, il ’68, il debito, l’inflazione, che altri attribuiscono come cause dell’inizio del periodo di crisi, e che poi e’ solo di rallentata crescita, secondo me sono avvenimenti collaterali di irrisoria importanza, epifenomeni.
Il punto e’ che una volta raggiunto il benessere, si possono aumentare la produzione e i consumi fin che si vuole, ma non aumenta il benessere.
Se queste considerazioni hanno qualche validita’, mi fanno ridere, e considero poco meno che serpenti incantatori, quelli che cercano di illuderci che, eliminando qualche banale intoppo, e magari seguendo anche i dettami della crescita sostenibile, torneremo oggi e senza dubbi a quel periodo di crescita in realta’ irripetibile, cosi’ ottenendo il solo risultato di condannarci all’eterna frustrazione per il mancato obiettivo, nonche’ all’aumento di debito.
Consiglierei la massima prudenza anche verso quelli che usano le istanze ecologiche (e vengono a loro volta usati da altri) per mantenere alto il livello di crescita dell’interscambio economico-monetario ufficiale (vedi la ragnatela ormai inestricabile di incentivazioni-normazioni), sottoponibile ad aggio e tassa, utile solo a tenere in piedi il castello di carte dell’economia formalizzata e finanziarizzata ***, pena il crollo del sistema economico contabilizzato, da non confondersi con quello reale. Cosi’ come non va confuso il benessere con il conto in banca: il marginalismo, qui riscoperto come legge dell’acqua calda ovvero dei ritorni decrescenti, in fin dei conti l’hanno teorizzato, nell’era moderna, per primi gli economisti post-marxisti e liberali della seconda meta’ dell’ottocento, ma non e’ che si tratti di chissa’ che grande scoperta recente: che “il troppo stroppia” e’ banalmente noto da millenni.
*** (flame!) nell’articolo mi pare si parli di debito e finanziarizzazione che tiene in piedi il sistema del fossile: ma guardate che il settore che in Italia sta godendo di piu’ dell’incentivazione e finanziarizzazione (pari a 10 miliardi di euro/annui, cioe’ 800 euri per famiglia di 4 persone, una cifretta ragguardevole, con un centinaio di miliardi di investimento a debito e a interesse) e’ quello dei vari conti energia del fotovoltaico. Trovate tutti i dati che volete, anche se un po’ nascosti, sul sito del gse/terna. Nel resto del mondo lo stesso vale per la conversione del parco automobilistico all’elettrico, probabilmente per alcuni l’affare del secolo, ma che forse mettera’ definitivamente in ginocchio le nostre gia’ precarie economie (una singola postazione di ricarica rapida di una tesla richiede una potenza di alimentazione come e piu’ di una macchina per risonanza magnetica nucleare… cioe’ enorme).
Non ho capito verso chi indirizzi i tuoi strali polemici. La questione fossili- rinnovabili è ovviamente intricata e non ho nemmeno provato a districarla. Suppongo che la crescita del debito e della finanziarizzazione siano una delle risposte agli intoppi nati dall’aumento della viscosità del flusso di risorse dalla natura all’economia. Parlando di ritorni decrescenti non intendevo scoprire nulla. Non siamo qui a fare sfoggio di cultura economica, ma per cercare di capire cosa succede e perché in modo sistemico cioè non guardando l’economia come qualcosa di separato dall’ecosistema in cui agisce. Per banale che sia, e lo è, non è in alcuna analisi sui mezzi di comunicazione, a parte pochi isolati come Ugo Bardi, Luca Mercalli e altri due. Fra questi mi ci sono messo anche io, tutto qui.
@Pardi
Il mio post voleva essere principalmente un completamento delle interessanti considerazioni di Comoretto sul debito, e suggerire percio’ come oggetto, all’interno della disquisizione sul peak oil, la grande illusione che ora e adesso alimenta le speranze della maggioranza degli elettori ed e’ quella del tornare alla crescita dei mirabolanti anni del miracolo economico (1948-68), che sono invece a mio avviso intrinsecamente irripetibili per il semplice motivo, piu’ facilmente comprensibile e condivisibile da tutti, che non si puo’ passare dal medioevo alla modernita’ piu’ volte nel giro di poco piu’ di mezzo secolo, al di la’ di ogni altra e piu’ complicata considerazione.
E’ la pretesa illusoria di un tale ritorno che, per prima, dal momento in cui il ventennio del miracolo economico e’ finito, alimenta il debito: l’aspettativa messianica, alimentata da demagoghi in pessima fede, di una crescita che non puo’ piu’ riverificarsi per motivi intrinseci ad essa stessa: che dal medioevo alla modernita’ si puo’ passare una volta sola per ogni millennio, non ogni decennio. E volevo mettere in guardia esplicitamente anche dal recente fenomeno, oggettivo, di sfruttamento dell’ideologia eco-green da parte dei grandi potentati economici e dalle potenti burocrazie opprimenti a autoreferenziali, per alimentare mega-investimenti a debito senza alcuna speranza di ritorno, che finiscono per alimentare un ulteriore BAU a ritorno decrescente, altro che per contrastarlo: attenzione quindi a non farsi ulteriormente strumentalizzare.
Quindi in effetti un intervento critico, il mio, che spero possa essere visto, in quanto tale, in luce positiva, dato che pare ormai assodato che il web, di suo, incentiva la formazione di piccole comunita’ tribali che se la cantano e se la godono del tutto ignare di eventuali uragani (sociali) che intanto spazzano via tutto: altro che “villaggio globale”… e chi non canta in coro al loro interno e’ il troll da identificare, isolare, ed espellere.
Sull’impossibilità di tornare a crescere come prima (o forse semplicemente di tornare a crescere) siamo d’accordo. Credevo fosse chiaro. Io stavo cercando di inserire la specificità italiana di paese di medie tecnologie, danneggiata dalla globalizzazione più di altri (ad es. la Germania), nel contesto di una crisi mondiale determinata da un rallentamento o aumento della viscosità, del flusso di risorse dalla natura all’economia e di rifiuti dall’economia alla natura. In pratica il fatto che stiamo toccando i limiti della crescita (o abbiamo cominciato a toccarli ancora prima). Sulla questione delle lobby green o dell’ideologia eco-green sono d’accordo anche su quello. Se vogliamo mantenere un certo grado di industrializzazione nella fase di rientro (e credo che lo vorremo) un’infrastruttura di energie rinnovabili farà comodo, ma non credo che potrà sostituire la baracca attuale. In particolare non sono un convinto assertore della mobilità elettrica. Sono un convinto assertore della riduzione della mobilità, della riduzione dei consumi e della riduzione della creazione di rifiuti (emissioni ed altro). Lo faremo volenti o nolenti, ma se si fa con un certo grado di organizzazione la discesa sarà meno traumatica. Non faccio parte di tribù permanenti, faccio parte di tribù ad assetto variabile. Purtroppo la nostra anima tribale non può essere annullata del tutto.
Pingback: Governo: si parla di spread, debito ed euro. Ma è il petrolio il vero problema |
Buon Luca, se “i migliori intenzionati si propongono di rilanciare proprio quella crescita indifferenziata basata sull’aumento del consumo pur che sia. Poi ci sono quelli che vogliono continuare a tagliare le spese, anche se nel recente passato l’effetto dell’austerità è stato deleterio.” Come se ne esce?
Nel mio piccolo: Uno sviluppo sostenibile, che sappia creare occupazione cambiando stile di vita, quindi la maniera di lavorare e vivere. Cambiare una cultura globale competitiva in una cultura collaborativa, inclusiva, partecipativa. Quindi una economia circolare, green e orizzontale (Swadeshi) che soppianti l’attuale economia capitalista, consumista, verticale.
http://www.decrescita.com/news/sviluppo-sostenibile-non-regge-piu-la-politica/
Non leggo accenni al problema della sovrappopolazione planetaria. Che invece penso sia la causa che sta al fondo di tutto.
Strano che tu non legga accenni alla crescita demografica perché è indicata chiaramente. Parlo di crescita di cose, persone e animali domestici.
Pingback: il picco del petrolio convenzionale: perché succede quel che succede) – cor-pus 15
la questione delle crisi è la questione del capitalismo; il capitalismo esiste come sistema dominante da circa 250 anni, prima solo l’Inghilterra lo ospitava in modo significativo; ora in questi due o tre secoli il numero di crisi epocali è stato elevato; basti pensare che ancora oggi diciamo è stato un 48 per inidcare l’effetto delle rivoluzioni del 1848, periodo che si procratinato fino al 1870 con un ‘inizio di conflitto mondiale, la Comune di Parigi; poi c’è stato un cnquantennio di sviluppo pacifico fra il 1870 e il 1915; poi un periodo di profondissima crisi fra le due guerre e poi un nuovo periodo di ricostruzione fra il 1950 e 1980 circa, poi è reiniziato un periodo di criisi eguerre anche se occorre dire che le guerre gli USA le hanno epsortate in soluzione continua dopo il 1973; ora legare tutto questo al picco dellel risorse mi appare quanto meno azzardato; certo ci sono delle specificità ma seocnod me una vera crisi delle risorse non l’abbiamo ancora vista.la sequenza crescita, crisi, guerra ricostruzione è una sequenza tipica che il capitalismo segue da sempre; non vedo oggi sostanziali differenze, vedo differenze, ma non ancora così ampie
Ciao Luca,
con l’articolo di Ugo di oggi sul Fatto state dando, finalmente, un’opinione politica della crisi. “Politica” nel senso della visione per il paese in termini di economia reale. “Dove vogliamo andare?”. Mi viene da pensare che se lo spread davvero misura l’affidabilità di un paese, rilanciare l’Italia nel senso della sostenibilità con energiche politiche energetiche ed ambientali tra qualche anno potrà anche essere negativo. Siamo un paese che deve essere legalizzato. E’ necessario ambire a vivere di servizi, turismo, agricoltura di alto brand e varia tecnologia.
Forse i colloqui 5S-Lega hanno fatto ragionare un po’ il secondo sui temi dei trasporti su ferro, delle politiche per energie rinnovabili o per la trasparenza nella PA, la lotta al dissesto idrogeologico, e anche ribadendo, ebbene sì, la cura pratica all’intolleranza del popolino, mettendo mano praticamente a tutta l’illegalità che oggi è resa possibile da inerzie diverse. Le situazioni macroscopiche di migranti illegali, i mega-campi zingari e altri orrori del suburbano italico che oggi testimoniano, ed alimentano, tutte le zone ed i mercati dello spaccio e della prostituzione.
Pensare di rilanciare le infrastrutture nel senso di costruire strade è assurdo. Il paese deve essere riallacciato con le ferrovie, i tram nelle città e le greenways. I turisti del mondo sognano di visitare il nostro paese così. O vediamo un futuro per i torpedoni diesel dal Milione di km? Con l’autista sottopagato per giornate da 18 ore.
E’ superata la dicotomia destra/sinistra? Non so, ma credo che 5S e Lega possano immaginare un piano idrogeologico nazionale (Tubeconomics) e un piano ciclabile nazionale (progetto WEB di Salvaiciclisti) più di Renzi M. e Silvio B.
Li credo più liberi di:
– ripensare l’Europa che, come spiega Varoufakis, è stata voluta da US per NON funzionare;
– tentare politiche di sviluppo locale dirette, efficentando la PA e valorizzando la meritocrazia;
– capire la funzione di produzione (capitale lavoro energia e materiali, di cui parlavo su Effetto Cassandra in “L’energia del capitale”) per arginare il processo di “cheap labour”, ben sapendo che “cheap oil is over”.
Un Governo del Cambiamento dovrebbe cogliere le opportunità del’IT e realizzare un collegamento tra il lavoro svolto dei cittadini ed i servizi di comunità fruibili (scuola, sanità, luce, gas, ecc).
Esempio: sei disoccupato? Pulisci un parco: ti accredito 30 euro della bolletta a puoi fare due visite mediche specialistiche. Follia? Non credo. Consentendo maggiore flessibilità del lavoro ed il suo decentramento (telelavoro), rendendo possibili usi alternativi del tempo, per genitorialità, produzione agricola, artigianale, ecc. Si fa sparire i denaro, specie i contanti e ci si svincola da debito, spread, e mercati. Tu lavori qui e qui acquisisci diritti. Sei cittadino. Niente economia informale (del precariato/mafioide).
Tornando al nodo cruciale dell’energia nell’economia della crisi, occorre ripensare a come sia l’inefficienza del sistema asfalto/gomma/motore a scoppio/discarica ad essere termodinamicamente inefficiente, rispetto ad uno rinnovabile/ferro/elettrico/riuso e porti alla società del buen vivir, eliminando molto rumore e rimettendo gli italiani in grado di pensare e, anche, ridere.
Giancarlo
Quindi, fammi capire, il nostro affannarci a studiare e capire il Picco del Petrolio sarebbe un’attività accademica finalizzata a comprendere un fenomeno interessante, forse passibile di fruttare pubblicazioni scientifiche da aggiungere ad un curriculum, e che per ora non ha effetti reali tangibili sulla nostra società? Cioè non stiamo toccando i limiti della crescita e quelle del Club di Roma erano tutte maltusianate d’accatto? Se così fosse avrei sbagliato tutto.
Pingback: L'Energia del Governo del Cambiamento – alcune idee | L'occhio di Romolo
Cottarelli è stato disinnescare. E ora?
@Luca Pardi
personalmente sono un feroce assertore delle mobilità elettrica..ma di quella cosidetta ‘light’..monopattini, bici, scooter..anzi ritengo che le due ruote a benza, ancora tanto di moda nelle città italiane, siano particolarmente sorprendenti..nel senso che esistano ancora..cosa che vent’anni fa mai mi sarei immaginato.
che poi il futuro si chiami mobilità per come la intendiamo oggi ho seri dubbi..
il futuro è il trasporto come servizio..e anche su questo quello che lei dice, seconde me, si avvicina molto a verità.
Un saluto.
stefano
“…Ma, soprattutto in Germania, non si forma debito pubblico e anzi, c’è un forte surplus che viene usato politicamente per indicare i “cattivi” dell’Europa….”
E’ la gigantesca truffa del “surplus commerciale”. I tedeschi, diversamente dagli altri, non pagano interessi. Né sul debito pubblico, né su quello delle aziende. Riassunto: le loro banche dragano soldi grazie agli interessi che paghiamo noi, mentre le loro aziende beneficiano di un costo di servizio del debito sostanzialmente nullo.
Questo giochino equivale a stampare moneta bancaria e metterla in mano solo a qualcuno (tedeschi); ma far pagare l’inflazione risultante a tutti (noialtri). Il gioco sta per finire, e scommetto che finirà in una terribile fiammata. Posso solo sperare di non bruciarmi troppo, ma sarà dura.